Ken Burns and Lynn Novick, autori di un fluviale docu sul Vietnam in 18 puntate, ne hanno preparate “solo” tre, ma toste, su Ernest Hemingway. Voce del protagonista Jeff Bridges; Meryl Streep, Keri Russell, Mary-Louise Parker e Patricia Clarkson le quattro mogli. Chissà che non cambi il mio difficile rapporto con il Grande Hem e il suo mito… Più che un giudizio di valore sull’opera (lungi da me l’idea e sai chissenefrega), conta il “percepito” – nel caso riguardo Il vecchio e il mare – di un ragazzino nell’Italia degli anni Sessanta/Settanta.
***
Fu scritto nel 1951 e pubblicato a settembre dell’anno dopo sulla rivista Life; nel dicembre del 1952 uscì in Italia per Mondadori, al numero 306 della collana Medusa, nella traduzione di Fernanda Pivano – leggo che è in libreria in questi giorni una nuova versione (con frattaglie marine annesse) di Silvia Pareschi sempre per la casa di Segrate.
Ma dicevo: quella che mi trovai tra le mani io – alle scuole medie – era la copia di un best seller per antonomasia nei canoni della borghesia del Boom: arrivato alla XVII edizione, portava la data del maggio 1969.
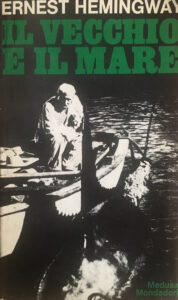
Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway fu dunque uno dei primi libri che non lessi. Fu per me ragazzetto quello che per un ciclista brocco avrebbe potuto essere il muro di Grammont, brevissimo ma assai ripido, nel Giro delle Fiandre.
Ecco: forse dovrei trovare un paragone acquatico, di geografia americo-cubana, ma in fondo trovo calzante l’accostamento ciclistico, perché il ciclismo parla sempre di uomini soli, al comando o meno, e impossibilitati ad aiutarsi tra loro – in molti al muro di Grammont facevano prima a scendere di bici e salire a piedi portandosela in spalla.
Anche in questa piccola nota ci sono due uomini soli, anzi tre – il terzo è Ernest Hemingway stesso -, impediti a trovare una mano amica nella loro vana battaglia.
Ossia: il pescatore Santiago che deve portare a riva il marlin catturato e si ritroverà a terra con una lisca spolpata dagli squali, e io che avrei dovuto sorbirmi un incredibile numero di pagine – erano in realtà 169 di cui una decina occupate dalle austere illustrazioni a china di Ugo Marantonio, poche dunque e ben spaziate, ma impervie come il muro di cui sopra – su una vicenda riassumibile in due righe. Dunque: Santiago prende il pesce, torna a riva, gli squali glielo mangiano. Lisca.
Che fosse un uomo solo Hemingway, invece, quasi non fa conto dirlo: ciò che conoscevo di lui, oltre a poco attrattive foto da ancient mariner in pensione, era sinistro: si era sparato una fucilata a Ketchum in Idaho il 2 luglio 1961, non riuscendo più a mettere insieme, come seppi dopo, vita e scrittura, saggezza e follia, tutto e nada, insomma, e viceversa.

Comunque. Tocco la mia copia del romanzo con la prudenza che si riserva a un feticcio letterario, tal quale me lo presentò il nugolo infervorato di professori delle medie. Proustianamente, ritrovo antichi stupori e sgomenti.
Mi chiesi ai tempi come aveva fatto Hemingway a tirarla così in lungo: la domanda però non si traduceva in fattiva curiosità di scoprire in che modo lo scrittore Premio Nobel – quando il Nobel, sorta di lastra tombale in vita, ancora intimidiva – fosse riuscito nell’impresa, ma mi abbandonava a un’apatica incredulità.
Certo: dieci pagine le occupi con le maledizioni al cielo che non ti fa pescar niente per 84 giorni filati: 84 era allora un numero magico come quello del brandy, lo Stock della pubblicità, e in fondo Hemingway stesso pareva fisicamente un testimonial da réclame del tonno a Carosello. Dieci le spendi per la bega con i genitori di Manolin, che ti negano il mozzo perché sei uno sventurato. Dieci nel descrivere la lotta col marlin, che all’epoca per me era un pescespada un po’ pinocchiesco e Wikipedia è invece prontissimo a definire, quasi dandogli una lustrata, “un marlin enorme, lungo circa 5 metri e mezzo, con delle strisce color viola che lo cingevano”. Bene. Via trenta pagine. Via altre dieci per le chine di Marantonio. Ma le rimanenti 129… che ci metti, che diavolo ci ha messo? Cioè – e arriviamo al punto – questa la sentenza a cui ero condannato da imberbe lettore: noia, noia mortale!
Aggiungo un altro motivo di diffidenza verso Il vecchio e il mare: esisteva una traduzione di questo presunto romanzo breve in lungometraggio. Il pescatore Santiago non era interpretato da un bell’attore seppure agé – un eroe insomma per quanto atipico in cui identificarmi – ma da quell’anziana talpa con la dentiera di Spencer Tracy – fu tra l’altro candidato in quel 1958 all’Oscar ma non vinse.
Spencer Tracy che infatti compare in un frame ritoccato in drammatico e pasticciato black & white sulla sovracoperta della mia edizione de Il vecchio e il mare, collana Medusa, maggio 1969.
Ancora oggi, non avendo visto il film, così come non lessi il libro, mi chiedo come pure il regista John Sturges abbia potuto riempire le due ore di proiezione salvo che offrendoci un’imbarcata di sbadigli. Né di certo migliorava l’attrattiva dell’opera filmica il fatto che la voce narrante in Italia fosse stata appaltata a un pacioso Gino Cervi pre Maigret.
Comunque. Cazzeggiando sulla probabile morte per noia, nel caso avessi affrontato il testo o il film, ho avuto d’improvviso più chiara, dopo una piccola giravolta di parole, una più nascosta ragione del mio adolescenziale atteggiamento di rifiuto.
Rifiutai Il vecchio e il mare per la noia – o piuttosto la paura, allargate voi il significato del termine noia – della morte che vi aleggiava attorno.
Non capivo perché, proprio dovendo, invece di un testo divertente e per di più considerato osé come Fiesta – era un bel Corallo della Einaudi con sovracoperta di Pablo Picasso – ci dessero in pasto come a poveri squaletti l’Hemingway imbalsamato, triste, solitario y final e formato testimonial del tonno, anzi tonno nella tonnara di The Old Man and the Sea.
Ritorno qui per la forza delle cose alla leggendaria fucilata con cui il vecchio marinaio Ernest Hemingway si uccise a Ketchum in Idaho il 2 luglio 1961. Quanto poco avevano dovuto consolarlo un premio per vecchi panzoni e scrittori già defunti in vita come il Nobel e questo supposto capolavoro sfigato di 169 pagine, per dire l’ultima cosa compiuta che gli era riuscita di scrivere…
Ecco: per me adolescente, Il vecchio e il mare era repulsivo anche perché puzzava e tanto di morte, quella che si propagava dal maestoso marlin – e insieme dal presunto e inerte capolavoro che probabilmente era o era diventato, a uso di una borghesia boriosa e delle prof delle medie che lo sfogliavano con atteggiamento da lugubri beghine – e la morte, dicevo, del suo immenso e travagliato, persino un po’ orchesco creatore.
Tra parentesi, solo di recente ho letto il bel libro di Olivia Laing Viaggio a Echo Spring (ilSaggiatore, 2018), quasi un pellegrinaggio sulle orme di scrittori alcolisti e, poiché Hem è uno degli indagati, assieme a Fitzgerald e Cheever, mi sono ricordato di altre opere per me illegibili di un funerario Ernest, sprofondato nell’infelicità creativa; cito le pagine pesanti di burocrazia funebre da safari o da corrida – mi risultò odioso in particolare Morte nel pomeriggio.
Ma poi. Lo leggerò mai L’uomo e il mare? Ma certo, ora. Nella doppia versione Pivano/Pareschi e anche in originale hemingweiese. Come no…

***
Domanda: cosa trovarono i borghesi italiani del Boom ne Il vecchio e il mare per farne quell’indiscutibile capolavoro da salotto buono? Be’. È un poema epico in forma giornalistica (cioè un testo molto “poetico” ma semplice da leggere e breve – molto più di quello che parve a me) per di più ambientato al presente (circostanza attraente per un romanzo che si presenta già da sé come un classico) che offre un’escursione esotica a costo zero (quasi una vacanza intelligente ante litteram); c’è poi per i credenti una pacifica metafora cristologica (le stigmate di Santiago) e per tutti la rassicurazione – da non trascurare, poiché i libri da salotto non possono instillare dubbi – che ai poveri e agli straccioni sarebbe andata sempre e comunque male.
Questo successo presso un pubblico tutto sommato poco sofisticato segna un buon punto favore al noto principio dell’iceberg, come enunciato da Ernest Hemingway: “Se un prosatore sa bene di cosa sta scrivendo, può omettere le cose che sa, e il lettore, se lo scrittore scrive con abbastanza verità, può avere la sensazione di esse con la stessa forza che se lo scrittore le avesse descritte. Il movimento dignitoso di un iceberg è dovuto al fatto, ecc. ecc…”
Riguardo la traduzione storica, riporto un giudizio di Piero Ambrogio Pozzi, americanista e autore di Il fiume, la laguna e l’isola lontana. Storia di Ernest e Adriana (Dragomanni): “L’originale del lungo racconto è costruito in assoluta semplicità lessicale, con personaggi umili e ambientazioni ridotte al minimo. Il ritmo è lento, dialoghi e monologhi sono brevi e poco articolati, espressi con la calma cadenza di chi ha tempo per pensare e parlare con le poche parole che conosce, usandole con naturale precisione. La versione corrente non rispecchia la semplicità dell’originale, e talvolta usa impropriamente parole rare o ricercate, con una stringatezza in contrasto con le intenzioni dell’autore e il carattere dei personaggi, tanto che contro la normalità il testo italiano risulta talora più breve di quello inglese”
(continua)
Credit “Ernest Hemingway” by Toronto History is licensed under CC BY 2.0 “Hemingway’s Underwood” by *rboed* is licensed under CC BY 2.0





